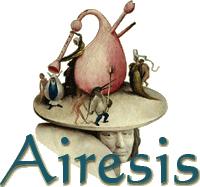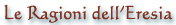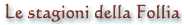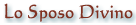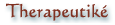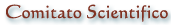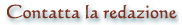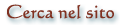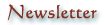Le rivoluzioni dimenticate�
Il Somnium di Keplero tra fonti neoplatoniche
e misticismo neo-pitagorico
Davide Arecco - Ricercatore e docente di Storia della scienza e della tecnica,�Universit� di Genova
L’importanza di
pitagorismo e platonismo in seno alla scienza moderna, dopo le ricerche
di Alexandre Koyr� e di Richard Westfall, � oggi pressoch�
universalmente riconosciuta. L'immagine pitagorica d’una natura
disposta dalla Divinit� secondo criteri e modelli numerici e, di
conseguenza, il ricorso alla matematica quale via di accesso
strumentale nella comprensione dei fenomeni, � un tratto distintivo
degli studi filosofico-scientifici tanto di Keplero quanto di Galileo.
Inoltre, nel caso del grande pisano, a Platone rimanda anche la
struttura dialogica delle opere fondamentali – 1632 e 1638 – nelle
quali l’impiego d’una maieutica socratizzante induce a riconoscere gli
errori epistemici racchiusi nella limitata prospettiva aristotelica. In
tal senso, la teoria della riminiscenza (e l’insieme delle possibilit�
euristico-gnoseologiche che offre) troneggia letteralmente nel Menone,
in relazione proprio al teorema di Pitagora. E pitagorica, si sa, �
anche l’idea, sia platonica sia neo-platonica, di una disposizione
armonico-musicale nella costruzione dei cieli e delle sfere planetarie.
Quella, per capirci, che ha contribuito a fare grande il Timeo,
rendendolo oltre modo affascinante per numerose generazioni di dotti e
studiosi.
� Il pitagorismo di Keplero � rintracciabile senza
fatica tanto nel Mysterium cosmographicum – pubblicato per la prima
volta a Tubinga, nel 1596, un anno prima che iniziasse il suo carteggio
con Galileo – quanto nell’Harmonices mundi (Linz 1619), con cui – a
tutti gli effetti, sul piano sia della storia del pensiero astronomico
(la riconferma del sistema eliostatico dei pitagorici), sia su quello
della stessa tradizione neo-platonica – si chiude un ciclo nella
cultura europea del primo Seicento.
Essa, specie nell’articolata
e complessa fase di passaggio dall’et� umanistico-rinascimentale a
quella barocca, riscopr� – in contrapposizione, spesso anche politica,
con l’Aristotele di scolastici e gesuiti – il verbo di Platone,
naturalmente con tutto il bagaglio di ascendenze che, da lui, rinvia
alla scuola di Pitagora ed ai versi aurei. La ricostruzione della
storia spirituale dei secoli XVI-XVII non pu� prescinderne. Il
difficile, semmai, � definire con esattezza le tappe di tale percorso e
l’intensit� del suo svolgersi.
� Ora, riconsiderare sul fronte
storiografico la presenza ed il grado di incisivit� della tradizione
neo-platonica (e orfico-pitagorica) ci fa ritrovare – tra gli autori ed
i testi di riferimento per Keplero, che qui prenderemo in esame – fra
gli altri il Somnium Scipionis ciceroniano ed il commento che, ad esso,
fece Macrobio nel IV secolo dell’era volgare, quando ormai (anche con
Giuliano Augusto) il paganesimo combatteva le sue ultime battaglie con
la fede cristiana, gi� divenuta religione di Stato e destinata a
conquistare il futuro.
� Keplero fu molto aiutato, nella sua opera
di riattingimento delle originarie fonti pitagoriche e neoplatoniche
dallo straordinario sviluppo della filologia classica, grazie agli
umanisti, nonch� dalla stampa, che ne diffondeva le edizioni riscoperte
e restaurate. Va precisato e subito che le fonti usate da Keplero,
ottimo grecista e latinista, furono quasi interamente antiche. Le tre
sole eccezioni di un certo rilievo restano, in ambito medievale, le
opere logico-mnemotecniche di Raimondo Lullo (per altro, nella
trattatistica kepleriana, di secondaria importanza e impiego
saltuario), mentre, in ambito quattro-cinquecentesco, maggiore impiego
l’astronomo tedesco fece degli scritti pichiani – nei quali pot�
rinvenire la definizione di aritmetica simbolica o formale,
corrispondente al compito assegnato gi� da Platone alla geometria e
presente in nuce anche nella Introductio airthmetica (II, 8, 125-294)
di Nicomaco, commentata da Giamblico – nonch� dell’edizione parigina di
Alcinoo (De doctrina Platonis, Lutetiae 1567). Facendo leva sul secondo
capitolo del commento di Alcinoo a Platone, poi di Plutarco
(Quaestiones platonicae, V, 1; VIII, 3-4), Keplero pot� saldare insieme
l’anno egizio, la tetractis e la stereometria. Infatti, nella
disposizione matematica dell’universo voluta dal supremo artefice, il
quinto poliedro della serie regolare ha dodici facce cos� come lo
Zodiaco ha dodici segni, ognuna delle quali � composta di cinque
triangoli (con il centro passante per il vertice comune), di cui
ciascuno � formato da altri sei (determinati dal diametro e da due lati
del pentalfa). Inoltre, dopo avere constatato che ognuna delle dodici
facce pentagonali del dodecaedro consta di trenta triangoli rettangoli
scaleni, Keplero pot� osservare, sviluppando le indicazioni plutarchee,
che il dodecaedro rappresenta tanto lo zodiaco quanto l’anno egiziano,
in quanto si suddivide nel medesimo numero di parti di esso.
L’importanza di queste osservazioni matematiche non sfugg� a Keplero,
che ne colse immediatamente l’origine pitagorica e platonica, attestata
da una lunga traditio.
� Questa, a sua volta, rinviava a
molteplici autori, vissuti in epoche anche differenti ma tutti pi� o
meno abbeveratisi a un’unica sorgente. D’altra parte, al tempo di
Keplero, dire Pitagora implicava affermare tutta una serie di nomi,
ognuno con la sua precipua importanza storico-filologica, a vario
titolo riportabili entro la matrice comune di una sola eredit�
esoterico-sapienziale. Alla saggezza di Pitagora e della cos� detta
scuola italica, in effetti, si poteva, gi� alle origini della scienza
moderna, risalire lungo una pluralit� di vie, tutte riportanti alla
medesima strada maestra.
Appena prima di Cartesio e di Fermat,
la stessa matematica – eccezion fatta per trigonometria e logaritmi,
recente bandiera dei novatores – verteva soprattutto sullo studio della
geometria, anche mediante il pitagorizzante Commentarium in Euclidem
scritto dal neo-platonico Proclo (V secolo), dell’algebra – sovente in
rapporto alla riscoperta umanistico-filologica di quella ellenistica,
come ci conferma il lavoro di Federigo Commandino su Apollonio di Perga
(le Coniche) ed Archimede – ed infine sull’aritmetica, fattasi a
partire dal Basso Evo sempre pi� concretamente mercantile e sempre meno
astrattamente speculativo-iniziatica.
� Sulla mistica sacrale e
aritmosofica del cenacolo pitagorico un Keplero poteva disporre quindi
di fonti molteplici e autorevoli: da Archita di Taranto e Filolao
(forse i matematici pi� eminenti del gruppo di Crotone, al maestro
vicini pure sotto il profilo temporale), da Aristeo a Ipsicle, da
Stobeo a Speusippo, da Diogene Laerzio a Teone da Smirne (quest’ultimo
matematico come Pitagora), da Ateneo alle Argonautiche di Apollonio, da
Oinopide (in assoluto uno dei primi pitagorici) al tramite romano
costituito da Cicerone. Il Somnium Scipionis di quest’ultimo, eclettica
sintesi di istanze neo-platoniche e stoiche, fu naturalmente un punto
di partenza irrinunciabile per edificare la costruzione
matematico-musicale dell’universo fisico-astronomico. Sul Somnium, in
particolare, Keplero pot� utilizzare i commentarii di Favorino e di
Macrobio. Di quest’ultimo, inoltre, lesse i Theologumena arithmetica,
che gli servirono per approntare il discorso sul misticismo dei numeri
consecutivi tre e quattro, i quali (moltiplicati) forniscono il dodici
zodiacale. In questa ripresa consapevole del legato pitagorico, poteva
soccorrere lo scienziato di fine Rinascimento anche una pi� lunga
tradizione dal gusto poetico-letterario, comprendente i Carmina di
Orazio, i Fasti e le Metamorfosi di Ovidio, sia l’Eneide sia le
Georgiche di Virgilio, alcuni passi sparsi nelle elegie di Tibullo e
Properzio, nonch� il commentario redatto da Servio alle Egloghe
virgiliane. In tutti loro si ritrovano richiami eruditi o pi�
dettagliate disquisizioni sul valore ieratico di terque quaterque, in
base a una tradizione la quale trovava alcuni suoi corrispettivi greci
in Alcmeone (pitagorico anch’egli), Timeo (al quale Platone intitol� il
suo capolavoro geometrico-cosmologico) e, da ultimo, nello
Pseudo-Plutarco della Vita Homeri (145).
� Per le argomentazioni
numerologiche kepleriane, come ovvio, furono essenziali pure Plutarco –
dal De Iside et Osiride (457) ai Placita philosophiae (I, 19), senza
dimenticare, nuovamente, le Quaestiones (2, 6, 9, 14) – Giamblico (De
vita pythagorica, 18 e 86), i noti Elementa theologiae di Proclo e il
Porfirio della Vita Pythagorae (51). Ma Platone stesso, del resto,
poteva anche con la sua Repubblica (V, 2; X, 617) rappresentare un
modello sempre valido. Non solo. La scansione insieme armonico-musicale
e matematico-geometrica del mondo tradiva anche, in Keplero, la lettura
tanto dell’Asinus aureus di Apuleio quanto di Vitruvio (De
architectura, IX, I) e di Filone alessandrino (De mundi opificio, X,
16, 34). A cementare il tutto, sia i richiami espliciti sia il corpo
sempre vivo e presente di suggestioni latenti, era – in Keplero, come
in molti altri contemporanei – il collante ermetico della Tabula
smaragdina e (visto che qui si parla di uno ‘scienziato’),
congiuntamente ad esso, quello naturalistico e neo-empedocleo.
� Keplero,
sulla soglia ancora spuria della scienza meccanicistica moderna, dava
per scontata, rifacendosi al Somnium di Cicerone, l’armonia
pitagorico-platonica del mondo, scrivendo che �duo sunt, quae nobis
harmonias in rebus naturibus patefaciunt, vel lux vel sonus�
(Harmonices mundi, liber V, caput IV).
� Argomenti che il grande
astronomo aveva gi� adombrato nel suo primo capolavoro, il Mysterium
cosmographicum, intriso di latenti motivi platonico-pitagorici.
Procedendo a ritroso, le prime testimonianze che attestano l’esistenza
di una musica celeste risalgono a Pitagora, il quale, secondo
Giamblico, era in grado di poter udire l’armonia degli astri in stato
di trance metafisica. Secondo la teoria orfico-pitagorica, ripresa da
Platone e rinata a nuova vita attraverso i neo-platonici, la stoffa
dell’universo era composta di ritmi, numeri e proporzioni, e,
considerando che gli intervalli muscali quali l’ottava, la quinta e la
terza si potevano ottenere facendo vibrare corde (le cui lunghezze
erano frazioni intere della lunghezza della nota fondamentale), lo
stesso si poteva dire per il cosmo, inteso quale perfetto sistema
armonico, i cui sette allora pianeti conosciuti (Sole, Luna ed i cinque
pianeti visibili) potevano essere messi in corrispondenza con le sette
note naturali.
In campo astronomico, Keplero fu il primo degli
scienziati moderni a parlare di armonia del cosmo. L’ordine che regna
nell’universo era, per lui, una forma di superiore armonia
rintracciabile e riducibile in chiave di concepibilit� umane, come
modello, nelle scale e negli accordi, nei generi e nei modi della
teoria musicale. Partendo dalla teoria copernicana, e credendo quindi
che alla base di tutti i fenomeni naturali risiedano leggi matematiche
(l’armonia cosmica, espressa da numeri), egli concretizz� l’armonia con
la geometria dei solidi, mettendo cos� in relazione il numero dei
pianeti e le dimensioni delle loro orbite (ellittiche, con il Sole che
occupa uno dei due fuochi), con i cinque solidi regolari. Pi� avanti,
nel tentativo di dimostrare le proporzioni armoniche esistenti tra i
pianeti, si serv� delle differenti velocit� angolari dei singoli
pianeti, in afelio ed in perielio, ovvero ad una distanza maggiore e
minore rispetto al Sole, e pot� notare che la velocit� era maggiore in
vicinanza di questo. Tali osservazioni lo portarono a proporre un
modello di sistema solare eliocentrico, dove, quindi, ogni pianeta
percorre un’orbita a forma di curva chiusa, pi� o meno allungata, in
cui il Sole occupa come detto uno dei punti interni ad essa.
Suggestioni e calcoli fatti propri in seguito (1687) da Newton, che li
unific�, nella sua filosofia gravitazionale, con la dinamica terrestre
galileiana. A garantire l’equilibrio all’interno del sistema solare, a
seguito di queste nuove speculazioni, vennero formulate dall’astronomo
tedesco le famose tre leggi (appunto, le ‘Leggi di Keplero’), che
regolano il movimento dei pianeti attorno al Sole, perno ad un tempo
divino e celeste del cosmo, confermate poi dai Principia mathematica
newtoniani.
� Secondo Jocelyn Godwin, Keplero risulterebbe, tanto
nel contributo dato alla scienza dei cieli, quanto nell’investigazione
musicologica, non l’ultimo grande dell’et� rinascimentale, ma il primo
di quella barocca. La prova si avrebbe dal metodo maturo, gi�
seicentesco e quindi moderno, con cui egli esamina le varie questioni
per ridiscuterle. Il Mysterium contempla e approfondisce la divisione
dello Zodiaco nei suoi aspetti astrologici, con intervalli
corrispondenti a distinzioni armoniche delle corde vibranti.
L’Harmonices, dal canto suo, tratta delle proporzioni tra i movimenti
planetari e del ruolo centrale rivestito dal Sole, moti e funzione
espressi, a loro volta, in un sistema di note della scala musicale (con
modi maggiori e minori). Vediamo, in tale maniera, illustrati i toni
planetari, gli intervalli enarmonici, sino alle melodie prodotte dai
pianeti o musica universale delle sfere celesti, in cui ogni parte �
rapportata al tutto. Il debito maggiore � quello che Keplero paga a
Nicomaco di Gerasa, al Timeo di Platone (l’idea della musica
planetaria) e ai neo-platonici tardo-antichi (Proclo, Porfirio,
Macrobio) e moderni (Pico, in misura minore lo stesso Ficino). Le
medesime fonti – con in pi� Marino di Tiro, biografo di Proclo – che
avrebbe in seguito utilizzato Newton. Nicomaco, pi� di tutti, doveva
coinvolgere il moderno uomo di scienza: il suo Enchiridion harmonices,
oltre a fare propria l’attivit� demiurgica dell’anima mundi, aveva il
merito indiscutibile di unificare, in una sola dottrina, scale
planetarie, acustica, riscoperta del pitagorismo, significati nasconti
nel Timeo e culto per l’ordine celeste (comune, quest’ultimo, anche a
Teone di Smirne), in una sorta di breviario neo-platonico e
neo-pitagorico. Non a torto, si pu� intravedere notevole somiglianza
tra Nicomaco, da una parte, e Macrobio, dall’altra. Nel suo commentario
al Somnium Scipionis, lunghe sezioni sono infatti dedicate da Macrobio
ai numeri di Platone e al loro significato, cos� come nei commentarii
di Proclo al Timeo e alla Repubblica ampio spazio � consacrato ai
suoni.�
Il sogno di Keplero
Alla tradizione
occidentale del Somnium Keplero si rifece in maniera esplicita nella
sua ultima opera, apparsa postuma di quattro anni, a cura Johannes
Erben. Il manoscritto era stato ritrovato dal figlio Ludwig, studioso
di medicina, tra le carte del padre, dopo la sua morte, avvenuta nel
1630. Il primogenito del grande astronomo tedesco acconsent� a
divulgare il testo, attraverso una apposita edizione a stampa. Questa,
con il titolo di Somnium seu opus posthumum de astronomia lunari, vide
la luce nella Francoforte dei Rosa-Croce, stampata dal Sagan, nel 1634.
Oltre al platonismo stoico di Cicerone e a quello neopitagorico di
Macrobio, il lettore poteva trovare nel libello anche Plutarco di
Cheronea. La seconda sezione della dissertazione kepleriana – dopo una
prima che riprendeva le argomentazioni cosmologiche del Mysterium e
dell’Harmonices, chiudendo si pu� dire un cerchio – presentava una
versione �e graeco latine redditus� del plutarcheo De facie in orbe
lunae, tradotto da Keplero stesso. Scelte non casuali. Si pu� affermare
che Keplero fosse tornato ai primi amori, nello specifico alle
suggestioni del credo aritmologico sposato la prima volta a fine
Cinquecento, appena prima di attendere alle opere maggiori. Torn� tra
l’altro a chiedersi perch� non percepiamo il suono eterno prodotto
dalla rotazione planetaria intorno al Sole centrale, adducendo una
spiegazione forse un po’ oziosa e psicologistica, comunque in linea con
il modello ciceroniano. Alla creatura umana non � dato di intendere il
divino monocordo delle sfere celesti orbitanti nel sistema
eliocentrico, non solo e non tanto in quanto l’anima � prigioniera del
corpo-carcere – immagine anche petrarchesca e shakespeariana (la
�caduca veste di fango� che fittamente ci avvolge, nel Merchant of
Venise) – ma piuttosto poich� l’abitudine ad ascoltare da sempre la
perenne armonia musicale del cosmo pi� non ci consente di distinguerne
l’intonazione timbrica dal silenzio. A Cicerone, d’altra parte, rinvia
pure l’artificio letterario che vuole – in questo caso, la moderna
astronomia lunare – rivelata in sogno al sapiente. Quest’ultimo, come
nella miglior tradizione greco-latina, � un uomo divinamente ispirato,
spiritualmente pronto ad accogliere la sofia dei numeri e delle scale
che costituiscono e dispongono l’universo, a fare propria
l’architettura e il linguaggio attraverso cui la natura � scritta. Un
universo – anche quello di Keplero – religiosamente ordinato, del quale
la Luna � mirabile rappresentazione in piccolo, quasi una riproduzione
modellistica in scala ridotta.�
� Dal Mysterium Cosmographicum, 1596
� Il Somnium kepleriano � un’opera
solo in apparenza di facile lettura. Il travestimento narrativo non
impedisce ad esempio all’Autore di diffondersi, nella parte centrale,
su dimostrazioni e calcoli matematici di notevole complessit� e
ricchezza, a supporto delle argomentazioni addotte. L’opera si apre,
come vogliono i crismi di un’epoca devota al mecenatismo, con la dedica
�all’illustrissimo ed eccellentissimo principe e signore Filippo,
langravio di Assia�, il conte che di Keplero fu munifico protettore.
Abbiamo quindi, corredato da apposite note e da un’appendice
geografica, il racconto del sogno vero e proprio. In realt� – diciamolo
subito – si tratta d’un finto sogno, d’uno sprofondare tra le braccia
di Morfeo del tutto immaginario. Keplero finge solamente di sognare ed
abbellisce il suo racconto con particolari autobiografici (il ricordo
della madre, presunta strega, connesso all’altro di Tycho Brahe, del
quale il giovane Keplero fu ‘apostolo’ nella Praga di Rodolfo II).
Siamo, in questa sede, al cospetto di una fantascienza ante litteram
(Keplero che, giunto sulla Luna, ne misura con la sua matematica le
altezze dei monti). Che cosa spinse l’astronomo tedesco – oltre al
neopitagorismo che abbiamo visto essere stato filtrato dalla tradizione
neoplatonica – a scrivere quest’opera? Al fine di rispondere, dobbiamo
tornare con la mente nella Praga del 1606. In quell’anno infuriava
infatti la discordia tra il sovrano del Sacro Romano Impero (il
succitato Rodolfo II) e l’arciduca d’Austria (il di lui fratello
Mattia). Le azioni dei due fratelli in contrasto tra di loro
richiamavano a tutti, come ha scritto Giovanni Godoli, precedenti della
storia boema. Fu cos� che Keplero, spinto dall’interesse di carattere
generale, cominci� a interessarsi delle leggende di quelle terre ed in
particolare della storia dell’eroina Libussa, allora molto celebrata
per le sue arti magiche. Una notte, quando la sua fantasia era ancora
piena di immagini esoterico-occulte e dopo avere a lungo riflettuto,
osservando la Luna e le stelle del firmamento celeste, cadde in un
profondo sonno e gli parve di leggere un libro magico, simile a quelli
di Libussa. Ecco l’occasio scribendi, a conti fatti un puro e semplice
artificio retorico al servizio dell’Autore. Il Somnium, di fatti,
rispecchia in una maniera abbastanza nitida, di l� dalle immagini e
finzioni letterarie, l’atteggiamento kepleriano, volto a divulgare con
efficacia il modello copernicano dell’universo. La prima parte del
Somnium � un racconto letterario, che ben esprime il copernicanesimo
dell’Autore. Viceversa, dopo la seconda parte matematica, la terza – in
merito alla quale scelgo di concentrarmi – presenta un saggio
astronomico, dietro cui si nasconde la filosofia di Pitagora e dei
neo-platonici. Vediamolo in dettaglio, provando a delineare la
metafisica scientifica che sta dietro all’astronomia kepleriana. Per i
rimandi testuali, rinvio alla traduzione del Somnium, a cura di Paolo
Aldo Rossi, che precede nel presente �Quaderno� questo mio intervento.
� Corrispondendo
con Galileo, un altro lettore di Plutarco, Keplero suppose che la
descrizione della superficie della Luna fornita dal grande pisano fosse
fortemente condizionata dai presupposti teorici copernicani, che lo
scienziato toscano aveva fatto suoi ormai da molti anni. Immagini
ottiche semplici possono implicare un articolato modello di spiegazione
scientifica. Schemi cosmologici e metafisici tra di loro differenti
hanno generato interpretazioni contrastanti della Luna vista a occhio
nudo. Le discussioni de facie Lunae – protrattesi per oltre duemila
anni, solo in parte ricostruite da Pierre Duhem – rimangono ancora oggi
un test circa il conflitto tra i sistemi del mondo, in contrasto tra di
loro sino alla nuova astronomia sviluppatasi tra XVII e XVIII secolo.
Nel Sidereus Nuncius, per descrivere le nuove evidenze ottiche –
avallamenti e crateri, montagne e cavit� site sulla Luna – Galileo fece
uso di una terminologia tradizionale. Le sue espressioni, per�,
ricalcavano alla lettera i passi della traduzione latina del De facie
in orbe lunae di Plutarco, fatta da August Xylander, che al grande
pisano era nota nell’edizione veneziana dei Moralia apparsa nel 1572.
Keplero la conobbe e utilizz� per confrontare la sua versione?
Rispondere � difficile, certo � che i grandi autori classici – come ha
sottolineato Paolo Casini – costituivano un codice di riferimento
sottinteso e comune quasi a tutti i dotti del Seicento. Tra questi
autori, Plutarco era uno dei pi� diffusi. Galileo aveva praticato e
tradotto i Moralia sin da ragazzo. La conferma ci viene proprio da
Keplero, che colse in maniera istantanea i rimandi plutarchei impliciti
nel Sidereus, come testimonia una lettera scritta da Giuliano de’
Medici a Galileo da Praga (19 aprile 1610).
� Keplero, in
corrispondenza con Galileo da quando era uscito il Mysterium
cosmographicum, inform� il collega italiano di avere letto Plutarco sin
dal 1593 – quattro anni prima, cio�, che il loro commercio epistolare
iniziasse – su indicazione dell’astronomo Michael Maestlin, il suo
maestro. E gi� allora aveva cominciato a fantasticare in merito agli
abitanti della Luna. L’anno prima, nel 1609, mentre Galileo lavorava
con il cannocchiale, si era immerso in profondit� nella lettura e
traduzione del De facie plutarcheo, componendo la sua nuova astronomia
per gli abitanti della Luna, geografia lunare esposta poi nel Somnium e
nella Dissertatio cum Nuncio Sidereo. La lettura di Galileo colse
dunque l’astronomo e matematico tedesco nel momento culminante della
sua ‘estasi’ plutarchea. Al momento di rendere partecipe delle proprie
emozioni il collega allora a Padova, Keplero non manc� di compendiare
la propria consuetudine spirituale con Plutarco, in una serie di
auto-citazioni. Nella Astronomia pars optica del 1604 aveva riletto il
De facie alla luce dell’eliocentrismo copernicano e aveva sostenuto che
la Luna � un’altra Terra, che non risplende di luce propria, che non �
liscia alla stregua di uno specchio, che la sua superficie aspra e
disuguale riflette la luce del Sole, come da vari specchi. Anche se su
alcuni punti – le tesi plutarchee sui mari e le cavit� della Luna,
sulle macchie luminose e le ombre oscure – Keplero dissentiva
dall’autore greco e concordava con la lettura esatta insegnatagli da
Galileo, per lui come per Plutarco la luce del Sole illuminava con
intensit� maggiore monti e pianure piuttosto che valli e depressioni
lunari.
� Nel De facie, ispiratore del Somnium kepleriano,
dibattendo riguardo le leggi della riflessione, Lucio aveva osservato
come in numerose circostanze la luce non si riflettesse affatto ad
angolo retto rispetto al raggio incidente. Ora, non possiamo dire qui
con sicurezza che Galileo abbia utilizzato la traduzione che di
Plutarco aveva fatto Gandino – un calco assai fedele del latino di
Xylander, come ha rimarcato Casini – e neppure che abbia parafrasato il
testo del De facie. Tuttavia, la presenza di Plutarco si avverte in
tutta la prima giornata del Dialogo. Elusiva, forse impalpabile, viva,
non nella lettera, ma nello spirito, tanto difficile da inquadrare
quanto impervio e problematico �, molte volte, il discorso della fonte
classica. E’ ovvio che Salviati oppone a Simplicio argomentazioni assai
pi� nette e conclusive di quelle usate da Lucio e Lamprias.
L’osservazione ravvicinata della superficie lunare, soprattutto la
scelta copernicana (comune anche a Keplero) permettevano a Galileo di
dare, come ha scritto Casini, tutt’altra forza probante alle intuizioni
degli antichi, i quali avevano visto la Luna come una seconda Terra.
Una delle pi� convincenti ‘sensate esperienze’ della prima giornata �
la successione di prove e ragionamenti con gli specchi. Ma l’idea
deriv� senz’altro dai giochi ottici descritti nel De facie in orbe
Lunae, modello di riferimento pure per il Somnium kepleriano. Quanto
poi alla possibile abitabilit� della Luna, all’ipotesi che sia
anch’essa ricca di acqua e di vegetazione, a prima vista pu� sembrarci
che Galileo si opponga, diversamente da un Keplero, alle elucubrazioni
plutarchee. Ma solo perch� lo scrittore greco non aveva potuto disporre
dei dati astronomici rivelati dal cannocchiale e resi pubblici con il
Sidereus.
� E’ lecito supporre che, nel complesso, Keplero avesse
visto giusto su Galileo. Quando questi, a partire dall’estate 1609,
punt� il suo cannocchiale sulla Luna aveva probabilmente gi� in mente
un modello di interpretazione dei fenomeni celesti, modello alternativo
a quello aristotelico-tolemaico e largamente suggerito dagli
interlocutori del dialogo plutarcheo. Strano, semmai, che Galileo non
abbia mai citato apertamente questa sua fonte greca, neanche nella
prima giornata del Dialogo, dove leggiamo di un immaginario Platone
visto quale fonte del celebre mito sulla caduta dei pianeti.
Prima
delle scoperte galileiane, Keplero aveva basato i suoi discorsi
congetturali a proposito della faccia della Luna su semplici dati
visibili a occhio nudo, al pi� su un’immagine lunare grande come una
moneta, riflessa, a sua volta, nella camera obscura dellaportiana. Come
ha notato Casini, non provava alcuna gelosia di mestiere di fronte alle
strabilianti rivelazioni ottiche di Galileo. Non faticava, detto
altrimenti, a rendersi conto della novit� a dire poco eccezionale che
quelle immagini racchiudevano, con la loro possibilit� di ingrandire
sino a trenta volte i corpi celesti allora noti. Ma allora perch� un
insistere cos� manifesto sulle antiche suggestioni plutarchee? Perch�,
a mio avviso, in Plutarco Keplero aveva intravisto quanto, in seguito,
da Galileo scientificamente confermato. Il Somnium stabil� tra i due,
nello spazio letterario della dimensione onirica, una linea di
continuit�, nascosta ma profonda, sfuggente ma reale.
� Per Casini
e chi scrive, al fine di intendere veramente il significato dei
richiami al De facie – espliciti in Keplero, impliciti in Galileo –
vanno per forza di cose posti tra parentesi gli sviluppi che la
selenografia ha conosciuto successivamente. In altri termini, dobbiamo
dimenticare qui le moderne mappe di mari e di crateri, cos� come le
trasmissioni video in diretta. Occorre riflettere sul fatto che
all’inizio del XVII secolo la Luna appariva s� come un’altra Terra, ma
come una terra incognita ed appena avvistata, carica di simboli e
suggestioni metafisiche, di leggende e speculazioni. Insomma, era la
Luna di Plutarco. Keplero, a differenza di Galileo, ne trasse fermenti
escatologici e fantasie platonizzanti. Fu diverso l’atteggiamento del
grande pisano, che sicuramente non lesse il Somnium, come non lesse –
mai per intero, limitandosi forse a sfogliarle – le altre opere
kepleriane. Galileo non mostr� alcun interesse per l’esito mistico e
spiritualizzante dell’opera plutarchea, condiviso da Keplero
nell’epilogo al suo Somnium, simile e diverso rispetto a quello di
Cicerone. Se Galileo non diede certo spazio al mito narrato dalla
figura di Silla, aveva comunque ben presente la discussione astronomica
affrontata nella prima parte del De facie. Quest’ultimo fu un vero e
proprio campo di battaglia, sul quale si misurarono teorie cosmologiche
tanto antiche quanto antitetiche. Traduttori, commentatori e filologi
hanno ancora di recente tentato di documentare lo sfondo concettuale
entro cui si muovono e discutono i singoli interlocutori. Si tratta
degli accademici Lucio e Lamprias – il narratore – del peripatetico
Aristotele, del geometra Apollonide, dello stoico Farnace, del
letterato Teone. I nomi rinviano ovviamente a personaggi e correnti da
noi facilmente individuabili. Si pu� affermare che in proposito nulla
sia stato, sia per lo scrittore Plutarco sia per il suo lettore
Keplero, casuale.
� Il dialogo plutarcheo, raffinato e forse un
po’ sofistico, mescola intenzioni teoretiche e spunti di conversazione.
Il filo conduttore si pu� cogliere, ad ogni modo, abbastanza
nitidamente. L’inizio del dialogo � andato perduto. Quanto ne resta �
la affermazione della reciprocit� di irradiamento tra Luna e Terra.
Lamprias, peraltro, rifiuta la funzione di rispecchiamento attribuita
ai nostri oceani e la credenza ad essa collegata che la superficie
lunare si comporti come uno specchio perfettamente levigato. Viene
respinta anche la tesi aristotelica che vorrebbe la Luna come un astro
composto di luce e di etere, al pari della stoica, che la vedrebbe
constare di aria e di fuoco sottile. La Luna � un corpo solido, duro e
pesante. E’ un’altra Terra, che ci guarda mentre la osserviamo. Per
dimostrare tale assunto, Plutarco fa uso di numerosi argomenti
(astronomici, meccanici, ottici, ontologici). Per prima cosa, la Luna �
trascinata nella sua orbita da una forza proiettiva, definita poi (da
Newton, in occasione degli scholia classici) inerziale. Lamprias passa
quindi a confutare in maniera precisa la concezione peripatetica di un
cosmo nel quale le due categorie di ‘alto’ e di ‘basso’ vengono intese
quali dimensioni assolute. Non esiste un centro assoluto, occupato
dalla Terra. Non esistono quattro corpi elementari e gli astri non sono
perfetti. La loro inalterabilit� � stata solo una chimera illusoria, un
sogno ingannevole fatto nella notte sbagliata.
� La Luna
plutarchea, in particolare, non pu� venire reputata un corpo perfetto,
in quanto la sua superficie � irregolare, scabra e piena di asprezze.
Un’idea, anche kepleriana, che il cannocchiale di Galileo conferm�
attraverso la certezza data dagli occhi. Inoltre, la Luna non �
attraversata dai raggi di luce emessi dal Sole, ma � dotata di
luminosit� propria, limitandosi a riflettere sulla Terra i raggi
solari, con intensit� maggiore o minore a seconda della posizione e del
grado di illuminazione. Una lunga digressione sulle eclissi sottolinea,
nel De facie, la loro somiglianza con le consuete fasi della Luna. La
luce cinerea non appartiene secondo Plutarco alla Luna, ma risulta,
piuttosto, il prodotto di subriflessioni di luce stellare e solare
dispersa nello spazio. Restano da esaminare le similitudini e le
analogie con gli specchi, che tanto colpirono le menti di Galileo e di
Keplero. Due volte le dramatis personae del dialogo plutarcheo
dibattono sulle leggi dell’ottica e, in particolare, sulle riflessioni
di tipo speculare. La Luna – afferma Lamprias – non si comporta come
uno specchio piano. Se fosse cos�, vi si vedrebbero riflesse l’immagine
circolare del Sole e quelle degli oggetti terrestri. N� pare possibile
paragonarla a uno specchio convesso, poich� in questo caso non
risulterebbe illuminata in maniera quasi del tutto uniforme. Queste e
altre suggestioni – al confine tra mito, filosofia e modelli letterari
– Keplero rielabor� per il suo Somnium, correggendo talora il racconto
ciceroniano.
In Keplero la teologia protestante si fonde con la
tradizione dei cinque poliedri regolari. Egli, infatti, trov� che i
raggi delle sfere inscritte e circoscritte all’ottaedro, all’icosaedro,
al dodecaedro, al tetraedro e al cubo fossero con buona approssimazione
proporzionali alle distanze massime e poi minime dal Sole
rispettivamente di Mercurio e di Venere, di Venere e della Terra, della
Terra e di Marte, di Marte e di Giove, di Giove e di Saturno.
All’esterno, la sfera delle fisse chiudeva ancora il sistema, mentre il
Sole centrale, con la sua anima motrix, faceva ruotare i pianeti.
Furono, si sa, tali calcoli ad avvicinare Keplero e Tycho, sino alla
venuta del primo a Praga nell’autunno del 1600: il tedesco divenne
l’assistente del danese all’Osservatorio di Benatky. Entrambi volevano
risolvere il problema delle anomalie di Marte, Keplero perfezionando la
sua complessa costruzione geometrica e Brahe approntando tabulae nuove
e affidabili. Alla morte del maestro, come noto, Keplero eredit�
carica, impegni e carte del grande danese. Il suo programma prevedeva
di determinare con esattezza sempre maggiore i parametri delle orbite
planetarie, onde potere dare una conferma inoppugnabile alla sua
immagine matematico-musicale dell’universo. Fattori neopitagorici e
neoplatonici, come si vede, orientarono quindi da subito la sua ricerca
astronomica. I successivi studi, i tentativi, la gioia delle scoperte,
le delusioni, si trovano ampiamente descritti nelle sue opere
posteriori: l’Astronomia nova, seu physica coelestis de motibus stellae
Martis (Heidelberg 1609), dove vengono enunciate le prime due leggi,
completate dalla terza, illustrata nell’Harmonices (secondo la quale i
quadrati dei tempi di rivoluzione stanno come i cubi dei semiassi
maggiori delle orbite, per cui il rapporto tra le velocit� massime e
minime dei pianeti � di tipo armonico-musicale). Le prime due leggi,
dal canto loro, vennero applicate alla meccanica planetaria
nell’Epitome astronomiae copernicanae, edita da Keplero in tempi e
luoghi differenti tra il 1618 e il 1621. L’opera � un trattato organico
di esplicita fede eliocentrica e insieme uno strumento efficacissimo
per la difesa delle nuove idee. Divent� nei paesi protestanti del Nord
Europa una sorta di Bibbia del copernicanesimo, lettissima ed oggetto
di continue riprese e riedizioni. Vi si trovano, riesaminate e
convalidate, anche le scoperte di Galileo, gi� oggetto di attenta
analisi nella Narratio de observatis a se quatuor Iovis satellitibus
erronibus (Frankfurt 1611).
� Tali ricerche kepleriane, guardate
nel loro insieme, innestano le suggestioni neo-platoniche in un quadro
assai composito: da un lato Keplero si rivela fortemente influenzato
dalla lettura del De magnete di William Gilbert, attribuendo natura
magnetica alla forza motrice che nel Mysterium egli aveva ritenuto
fosse esplicata dall’anima del Sole; dall’altro l’astronomo tedesco
richiam� – con la legge delle aree, ad esempio – similitudini con le
ricerche infinitesimali di Archimede e con quella delle orbite fece uso
invece della teoria sulle curve algebriche contenuta nelle Coniche di
Apollonio che la filologia umanistica dei matematici rinascimentali
aveva rimesso a disposizione.
� Keplero sintetizz� pertanto pi�
‘momenti’ nella storia del pensiero astronomico: sostitu� alla
astronomia dei cerchi quella delle ellissi; conferm� l’importanza
essenziale di una base osservativa vasta e accurata per i progressi
dell’astronomia (come voleva Tycho); mise quest’ultima al servizio
della concezione di un’azione esercitata dal Sole per muovere i
pianeti, a sua volta motivata pi� da convinzioni metafisiche che da
certezze scientifiche. Keplero us� le sue tre leggi al fine di appagare
le proprie aspirazioni mistico-pitagoriche (rimaste pressoch� intatte
dal Mysterium al Somnium) e per computare le tavole rudolphinae
(pubblicate ad Ulm, nel 1627). Salv� quel che di valido restava nel De
revolutionibus di Copernico: la sola idea eliocentrica, religiosamente
vissuta.�
Considerazioni conclusive
Keplero non
fu il primo, n� l’unico, tra i neo-pitagorici rinascimentali.
Impossibile, in merito, non pensare dapprima a Johannes Reuchlin,
l’ebraista tedesco che forse per primo reintrodusse nel pensiero
occidentale il verbo degli Aurei detti, accorpandone il messaggio
soteriologico a quello del cabbalismo cristiano, sul limitare ultimo
del secolo XV. Ma rimane impossibile non pensare anche a John Dee –
matematico e astrologo, medico e mago, viaggiatore e scrittore politico
– il quale riport� Pitagora in Inghilterra, collegandone l’eredit�
italica e neo-platonizzante all’altra (mistico-arturiana e
druidico-celtica) della tradizione inglese. Miti, che tornarono a
vivere sotto diverso aspetto dopo i contributi della scienza
seicentesca. E sempre tra Settecento e Ottocento, specie in Francia: il
secolo dell’Illuminismo dapprima vide il Pitagora cristianizzato (non
senza salti mortali) da Saint-Martin e quindi mor� celebrando, ancora
all’interno di itinerari massonici, il pitagorismo romantico di Fabre
d’Olivet. Lungo tale cammino, sotterraneo ma non eccessivamente
tortuoso, le fonti neo-platoniche di Keplero andarono spesso obliate.
Pi� vicino alle testimonianze classiche e tardo-imperiali, certo in
un’ottica ancora fortemente umanistica, l’astronomo tedesco evit� le
contaminazioni e restitu� la filosofia religiosa di Pitagora alle
esigenze concettuali del moderno sapere scientifico. Non stupisca pi�
di tanto il continuo riferirsi della Massoneria (da Locke in avanti) ai
pitagorici. Il neo-platonico Massimo di Tiro per primo aveva denominato
‘arte regia’ la sapienza del maestro di Crotone. E arte regia, si sa,
dal XVII secolo in poi, sta a indicare tanto l’alchimia quanto la
Libera Muratoria, come ha rammentato nei suoi fondamentali studi Arturo
Reghini.
� Per finire, trovo quasi irriverente non ricordare –
anche se, d’altra parte, dovrebbe essere cosa nota – che
l’eliocentrismo copernicano di Keplero (e di Newton) � in ultima
istanza quello espresso dal pitagorico Aristarco di Samo, tre secoli
circa prima di Cristo. La tanto decantata definizione di ‘rivoluzione
astronomica’ – abusatissima, in effetti – dovrebbe al contrario fare
riflettere su un dato importantissimo di partenza. Latinamente,
revolutio deriva da revolvere e sta quindi a designare una condizione
di ripristino (di un antico sapere ‘ancestrale’), di restaurazione
(dell’antico pitagorismo eliostatico), di ritorno (orbium coelestium).
Quella che tante volte noi celebriamo alla stregua di una rivoluzione,
modernamente intesa, altro non � – sul pi� severo e corretto piano
etimologico – che la riscoperta di quanto era stato perduto, dall’uomo
e dal tempo. Cos� la intesero Keplero e Newton, i quali pagarono con
somma gioia il loro debito verso la tradizione pitagorica, giunta sino
a loro, non senza sovrapposizioni, tramite il medium neo-platonico e in
particolare il Somnium ciceroniano.
��� Bibliografia
�� �L. ALESSIO, Pitagora, Milano 1940.
�� �J.J. BACHOFEN, Pitagora, in Storia del matriarcato, Milano 1949, pp. 230-238.
�� �P. CASINI, Il Dialogo di Galileo e la Luna di Plutarco, in Novit� celesti e crisi del sapere, Firenze 1983 (a questo saggio sono profondamente debitore per la stesura del mio).
�� �P. CASINI, Pythagore en France � l’aube des Lumi�res, in Hommage � Ren� Pomeau, Oxford 1987, pp. 245-254.
� � P. CASINI, The Wisdom of the Ancient Italian Philosophers, in Transactions of Seventh Congress on Enlightenment, III, Oxford 1988, pp. 557-564.
�� �P. CASINI, Pythagore en Angleterre dans la seconde moiti� du XVIIe si�cle, in Enlightenment Essays in Memory of Robert Schakleton, Oxford 1988, pp. 27-38.
�� �P. CASINI, Il mito pitagorico e la rivoluzione astronomica, in �Rivista di filosofia�, LXXXV, 1994, pp. 7-33.
�� �P. CASINI, L’antica sapienza italica. Cronistoria di un mito, Bologna 1998.
� � P. CASINI, Newton, la ‘prisca philosophia’ e il pitagorismo copernicano, in Forme del neplatonismo. Dall’eredit� ficiniana ai platonici di Cambridge, a cura di L. SIMONUTTI, Firenze 2007, pp. 441-459.
�� �A.E. CHAIGNET, Pythagore et la philosophie pythagoricienne, I, Paris 1874.
�� �A. DELATTE, Etudes sur la litt�rature pythagoricienne, Paris 1915.
�� �P. DUHEM, Le syst�me du monde, IX, Paris 1958.
�� �R. GU�NON, Il risveglio della tradizione occidentale, Roma 2003.
�� �J. GODWIN, Music, Mysticism and Magic, London 1986.
�� �J. GODWIN, Cosmic Music, West Stockbridge 1987.
�� �J. GODWIN, The Harmony of the Spheres, Rochester 1993.
�� �J. GODWIN, Harmonies of Heaven and Earth, Rochester 1995.
�� �N.R. HANSON, I modelli della scoperta scientifica, Milano 1978.
�� �J. KEPLER, Opera omnia, a cura di C. FRISCH, I-VIII, Frankfurt 1858-1871.
�� �J. KEPLER, Gesammelte Werke, I-XX, M�nchen 1937 e segg.
�� �J. KEPLER, Somnium, a cura di G. GODOLI – DOLIOSEN, Roma 1984.
�� �A. KOYR�, Introduzione a Platone, Roma 1973.
�� �S.A.E. LEONI, Le armonie del mondo, Genova 1988.
�� �G. LORIA, Storia delle matematiche, I, Milano 1982.
�� �G. LORIA, Le scienze esatte nell’antica Grecia, Milano 1987.
�� �C. MACCAGNI, Galileo and cosmology, in Galileo scientist. His Years at Padua and Venice, Venezia 1992, pp. 61-75.
�� �A. MIELI, Le scuole jonica, pythagorica ed eleatica, Firenze 1916.
�� �M. NICOSIA, La tradizione pitagorica e la Massoneria, in Le radici esoteriche della Massoneria. L’arca vivente dei simboli, a cura di M. BIANCA – ANCA II LUCA, Roma 2001, pp. 67-87.
�� �PITAGORA, I versi d’oro, Roma 1959.
�� �A. REGHINI, Aritmosofia, Milano 1980.
�� �A. REGHINI, I numeri sacri nella tradizione pitagorica massonica, Genova 1988.
�� �A. REGHINI, Numeri sacri e geometria pitagorica, Genova 1988.
�� �A. REGHINI, Dei numeri pitagorici, Ancona 1991.
�� �P.A. ROSSI, Il �mistico� sogno di Cartesio al calore di una stufa, in questo volume.
�� �A. ROSTAGNI, Il verbo di Pitagora, Torino 1924.
�� �G. SEMPRINI, La filosofia di Pico della Mirandola, Milano 1936.
�� �M. SERRES, Le origini della geometria, Milano 1994.
�� �A. SIOUVILLE, Les Vers dor�s de Pythagore, Paris 1913.
�� �T. TAYLOR, The Mystical Hymns of Orpheus, London 1824.
�� �T. TAYLOR, The Theoretic Arithmetic of the Pythagoreans, Los Angeles 1934.
�� �R.S. WESTFALL, La rivoluzione scientifica del XVII secolo, Bologna 1984.
�
�
Articolo riprodotto per gentile concessione dell'autore, che ne detiene i diritti. Riproduzione vietata con qualsiasi mezzo.