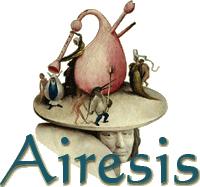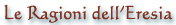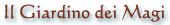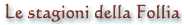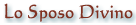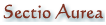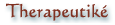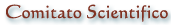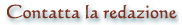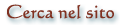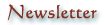Jean Reyor, tra revelatum e iniziazione
Massimo Marra
A compimento dell'opera di Ren´┐Ż Gu´┐Żnon. Vol. 3: Studi sull'esoterismo cristiano
di Jean Reyor
Ed. Pizeta, Milano 2002 - pag. 265 - € 25,00
´┐Ż uscito in edizione italiana, edito della Pizeta - una casa editrice che sta profondendo sforzi interessanti nella traduzione ed edizione di opere di esoterismo e storia delle religioni - il terzo volume della trilogia di Jean Reyor che reca il titolo, gi´┐Ż intrigante di per s´┐Ż, di "A compimento dell'opera di Ren´┐Ż Gu´┐Żnon", un testo la cui edizione francese era uscita per i tipi della Arch´┐Ż tra il 1988 ed il 1990.
Ci pare inutile ribadire quanto l'opera di Ren´┐Ż Gu´┐Żnon rivesta un ruolo importantissimo nella filosofia novecentesca, per quel che il metafisico francese ha sistematizzato ed intuito nelle sue opere. Il sistema di approccio al sacro elaborato dal Gu´┐Żnon ha prodotto una vasta platea di studiosi del sacro e dell'esoterismo che utilizzano il linguaggio gu´┐Żnoniano, creando, di contro, anche un poco edificante stuolo di "fedeli" che, pi´┐Ż che utilizzare correttamente il Gu´┐Żnon studioso, appaiono impegnati in una sorta di deificazione dell'opera del loro maestro, dando abbondanti manifestazioni di dogmatismo e, cosa assai peggiore, di ignoranza ed approssimazione.
Tali degenerazioni hanno propiziato la nascita di un milieu, che possiamo considerare trasversale a varie tradizioni, da quella massonica a quella sufi, fino ad arrivare a settori che si richiamano alla tradizione cristiana, che utilizza il tradizionalismo gu´┐Żnoniano quale griglia ermeneutica privilegiata nell'approccio al sacro, non senza generare, talvolta, equivoci e difficolt´┐Ż metafisiche e teologiche e postulando una universalit´┐Ż delle teorie gu´┐Żnoniane che ´┐Ż, nella migliore delle ipotesi, tutta da verificare[1].
Referenti di questo tipo di posizione sono un'intera generazione di successori, eredi e glossatori dell'opera gu´┐Żnoniana, che, nell'arco degli ultimi decenni, hanno avviato una riflessione ulteriore ed un approfondimento del corpus gu´┐Żnoniano nella sua applicazione ai diversi domini iniziatico-religiosi.
Tra gli epigoni pi´┐Ż interessanti del Gu´┐Żnon vi ´┐Ż senz'altro Jean Reyor (pseudonimo di Marcelle Clavelle, 1905-1988), a lungo collaboratore di fiducia di Gu´┐Żnon nella direzione di Le Voile d'Isis e di Etudes Traditionelles. La raccolta di cui ci occupiamo comprende una serie di articoli apparsi tra il 1950 ed il 1970 su Etudes Traditionelles e su Le Symbolisme, ed ´┐Ż articolata in tre volumi complessivi, di cui il primo ´┐Ż dedicato all'analisi ed all'approfondimento di tematiche emergenti dalla lettura degli Aper´┐Żus sur l'Initiation di Gu´┐Żnon, il secondo ai rapporti tra iniziazione massonica e chiesa cattolica, ed il terzo, forse il pi´┐Ż interessante, ad una serie di puntualizzazioni sull'esoterismo cristiano che prendono le mosse dagli scritti gu´┐Żnoniani sull'argomento
Il lavoro presenta ampi spazi di riflessione dedicati ad approfondimenti che vanno da considerazioni sulla lingua delle scritture sacre del cristianesimo, ai prestiti islamici ed ebraico-cabalisti alla tradizione cristiana, fino all'esoterismo templare, rosicruciano ed alla mistica di Meister Eckart. Una parte degli scritti raccolti ´┐Ż costituita da recensioni che l'autore ha redatto nel corso della sua collaborazione alle riviste citate in precedenza.
Si tratta di un ampio ventaglio di argomenti e riflessioni che accompagnano il lettore nei terreni, spesso scivolosi, di ipotesi ermeneutiche spinte talvolta ai limiti della verosimiglianza storica e filosofica, terreni tuttavia non scevri di intuizioni stimolanti e notizie utili.
Ci preme poco entrare nel merito delle singole tesi sostenute dal Reyor: ci´┐Ż richiederebbe un tempo e uno spazio superiori a quelli offerti da semplice recensione, seppur lunga ed approfondita. Ci interessa invece identificare quanto, nell'impalcatura stessa dell'analisi gu´┐Żnoniana, cui fa riferimento il Reyor, genera a nostro avviso una profonda incomprensione di taluni aspetti della tradizione cristiana.
La base delle analisi presentate appare essere un particolare concetto di essoterismo, che funge da sottofondo costante degli scritti dello studioso francese. Per il Gu´┐Żnon, l'esoterismo si configura, come un qualcosa di parallelo ed indipendente dall'exoterismo[2], ovvero, nel caso del cristianesimo, dall'insieme di dottrine e liturgia che costituisce la base stessa della rivelazione e del rito cristiano. Questa tradizione che si dipana, nel segreto della trasmissione iniziatica, dai primi cristiani fino alla modernit´┐Ż, rappresenta l'essenza stessa della realizzazione tradizionale. Al dominio che Gu´┐Żnon definisce come religioso o exoterico non spetta che una possibilit´┐Ż realizzativa in larga parte legata al dominio della morale e di una devozione passiva, o al pi´┐Ż di un confuso misticismo. Non si tratta di punti di vista del tutto originali, essendo concetti di questo tipo la base fondante delle teorizzazioni magico-occultistiche a cavallo tra XIX e XX secolo[3]. La distinzione - che mostra, del resto, una sensibile indifferenza per gran parte della produzione dottrinaria ed ascetica dei Padri della Chiesa - diviene per il Gu´┐Żnon una vera e propria contrapposizione quando si prenda in considerazione il misticismo, che, per l'esoterista francese, rappresenta l'antitesi assoluta di ogni percorso iniziatico[4].
La natura degli insegnamenti esoterici ´┐Ż tale da costituire, talvolta, un qualcosa, di totalmente altro ed incomprensibile per il dominio exoterico e religioso. L'esoterismo risulta un "pi´┐Ż", uno stadio di conoscenze principiali superiori rispetto al "meno" dell'exoterismo.[5] A quest'ultimo ´┐Ż demandato il compito della pura e semplice "salvezza" dell'individuo, che potr´┐Ż sperare di raggiungere altri piani di esistenza, invece, solo accedendo ai riti ed agli insegnamenti propri del dominio iniziatico.
Si tratta di una reificazione di due aspetti ermeneutici che il cristianesimo, naturalmente, non conosce affatto. Non vi ´┐Ż alcuna evidenza storica dell'esoterismo che Gu´┐Żnon crede di rintracciare in autori come Dante o in ambienti come quelli della cavalleria medievale[6]. Piuttosto, si rileva la presenza di due piani di approccio conviventi e tradizionalmente complementari all'unico revelatum del messaggio cristico. Ogni altro punto di vista presupporrebbe uno sdoppiamento del revelatum di cui non si ha traccia dottrinaria e che minerebbe le basi stesse ed i presupposti della dottrina cristiana. Di l´┐Ż di questa reificazione, tanto pi´┐Ż ingiustificata quanto meno fondata storicamente, e del tutto scollegata dalla storia teologica e dottrinaria del cristianesimo, rimangono altri punti oscuri di un tale "esoterismo cristiano". ´┐Ż abbastanza strana, infatti - soprattutto per la confessione religiosa pi´┐Ż diffusa sul globo - che un tale esoterismo sia totalmente ignoto quanto ai suoi rappresentanti ed ai suoi cardini dottrinari. Difatti non si hanno esempi storici di un esoterismo totalmente nascosto,[7] essendo la funzione di una scuola esoterica - nell'interpretazione gu´┐Żnoniana - quella di guidare gli uomini che sono qualificati al superamento dell'exoterismo religioso. Funzione, ovviamente, impossibile da compiere nell'ambito di una segretezza assoluta che impedirebbe di fatto ai presunti qualificati, di raggiungere i centri autorizzati ad impartire l'insegnamento. Del resto, per tagliare corto, basterebbe sottolineare che in nessuna altra tradizione esistono centri iniziatici, per quanto elitari, del tutto nascosti e tali da non lasciare alcuna traccia storica.
Un elemento rintracciabile in tutti gli scrittori e i teorici vicini all'elaborazione gu´┐Żnoniana e che ne inficia in modo assai serio l'ermeneutica ´┐Ż la preoccupazione di stabilire la conformit´┐Ż della tradizione cristiana al modello tradizionale astratto elaborato dall'esoterista francese, che soffoca ogni possibilit´┐Ż di considerare le tradizioni in s´┐Ż, ovvero, nel caso del cristianesimo, sulla base degli elementi scritturali e teologici. Ci´┐Ż, nel contempo, impedisce di cogliere l'aspetto completamente nuovo della rivelazione contenuta nei vangeli, che, d'altronde, vi ´┐Ż chiaramente annunciata.[8] Lo squarciamento del velo del tempio che segue al sacrificio cristico[9], e che rappresenta proprio la rottura dell'intero universo tradizionale che rappresentava il termine di riferimento dell'ebraismo, perde cos´┐Ż ogni sostanziale rilevanza, in virt´┐Ż di una cecit´┐Ż che coinvolge, oltre alle scritture sacre stesse, anche i secoli - pi´┐Ż precisamente i millenni - della produzione ermeneutico-teologica del cristianesimo. Il velo squarciato e la nuova alleanza annunciata dall'apertura del sancta sanctorum, cos´┐Ż come l'incarnazione ed il mistero virginale ad essa connesso, costituiscono elementi di alterit´┐Ż che, nell'analisi gu´┐Żnoniana rivestono, con ogni evidenza, una importanza relativa. Sostanzialmente, in virt´┐Ż della necessit´┐Ż di piegare tali peculiarit´┐Ż alla propria griglia ermeneutica precostituita, si ignorano i cardini stessi della rivelazione, intorno ai quali sarebbe ben difficile tessere trame di accostamenti ed interrelazioni, o identificare prestiti da altre tradizioni. Curiosamente, sembra che nelle analisi gu´┐Żnoniane il centro stesso delle dottrine cristiane, il punto focale della rivelazione evangelica, l'incarnazione, non provochi alcuna considerazione neanche dal punto di vista esoterico. I concetti di esoterismo, exoterismo, iniziazione - nella loro accezione gu´┐Żnoniana - divengono in tal modo elementi di riferimento astratti di un giudizio di valore che elude costantemente i riferimenti scritturali, teologici, ascetici, e che ignora del tutto la tradizione patristica. ´┐Ż un po', si parva licet, come voler fare il falegname ignorando la sega, i chiodi e la pialla...
Senza spingerci oltre nella considerazione della verosimiglianza delle ipotesi esoteriche gu´┐Żnoniane in merito al cristianesimo, cosa che ci porterebbe troppo lontano dagli scopi e dagli spazi che ci siamo prefissati, e che, inevitabilmente, finirebbe per coinvolgere alcune delle concezioni fondanti dell'intero sistema gu´┐Żnoniano, ritorniamo ora al Reyor, che, abbiamo l'impressione, abbia inclinazione pi´┐Ż marcata al cristianesimo che non il suo maestro. Il testo di Reyor ´┐Ż, sostanzialmente, una serie di utili glosse a quanto Gu´┐Żnon dice su diversi aspetti della tradizione cristiana in alcune sue opere - e, segnatamente, nella raccolta Aper´┐Żus sur l'´┐Żsot´┐Żrisme chr´┐Żtien, uscita postuma nel 1954. Particolare attenzione, se cos´┐Ż possiamo dire, ´┐Ż dedicata alla radice ebraica del presunto esoterismo cristiano, che il Reyor affronta sia per quanto concerne la questione della lingua sacra, sia in rapporto alla cabala cristiana. Anche in questo caso ci troviamo di fronte all'ipotesi di fondo, di cui ci si accorge chiaramente nel corso della lettura, che il cristianesimo delle origini sia una sorta di evoluzione dell'esoterismo ebraico[10], rispetto al quale esso avrebbe rapidamente segnato il passo con una pi´┐Ż o meno massiccia exoterizzazione, ovvero una esteriorizzazione cerimonialistica degli originali riti esoterici. Anche in questo caso, invece, la critica recente ha evidenziato la totale estraneit´┐Ż, reperibile al livello scritturale, tra l'ebraismo ed il cristianesimo, gi´┐Ż all'epoca della redazione degli Atti degli Apostoli.[11]
Ci pare, tutto sommato, che il Reyor non sposi totalmente, nell'attenzione che dedica alla tradizione cristiana, le tesi del suo maestro, ricavandosi, in ci´┐Ż, un territorio di riflessione autonomo che non porta necessariamente il lettore alle conclusioni gu´┐Żnoniane. Reyor non fa menzione esplicita di una degenerazione tradizionale del cristianesimo, n´┐Ż, a quanto ci ´┐Ż tramandato, a questo si limita la sua specificit´┐Ż ermeneutica. Il Reyor trae, in pratica, dal Gu´┐Żnon, la sola acritica certezza di una tradizione esoterica cristiana segreta e totalmente indipendente dall'exoterismo religioso, senza sposare manifestamente quell'idea dell'"abbassamento" exoterico della rituaria cristiana e dei sacramenti, che costituisce uno dei capisaldi gu´┐Żnoniani della critica al cristianesimo.[12]
In generale, comunque, in questi scritti sulla tradizione dell'esoterismo cristiano, scritti che, ripetiamo, rivelano una inclinazione pi´┐Ż evidente all'argomento di quella manifestata dal Gu´┐Żnon[13], e che non sono privi di spunti interessanti ed annotazioni feconde, il Reyor non si affranca efficientemente dalla matrice filosofica gu´┐Żnoniana e dai suoi forti limiti ermeneutici. Il retroterra di riferimento, in sintesi, genera difetti di approccio e di inquadramento analitico che ci paiono rilevanti, e che, forse, contribuiscono ad evidenziare, al lettore sufficientemente attento, la sostanziale estraneit´┐Ż ed insufficienza dell'impianto storico, teoretico ed ermeneutico utilizzato nei confronti degli aspetti scritturali e teologici del cristianesimo. I testi di Reyor, tuttavia, costituiscono un ausilio importante per delineare il carattere ed i limiti di alcuni assunti gu´┐Żnoniani fino a tempi recenti assai poco studiati, e che nelle opere stesse del maestro francese appaiono esposti talvolta senza il sostegno di riscontri dottrinari, e senza alcuna considerazione dei dati che, pure, la tradizione cristiana ha trasmesso in modo inequivocabile.
´┐Ż
Note
[1] Si ´┐Ż pi´┐Ż volte sottolineato ad esempio come alcune posizioni in merito all'unit´┐Ż trascendente delle religioni, nella forma in cui tale concetto emerge dagli scritti di Gu´┐Żnon, abbiano suscitato forti perplessit´┐Ż da pi´┐Ż parti. Si pensi ad esempio alle obiezioni espresse da un Henry Corbin, o agli studi recenti di un Borella (si veda in particolare Esoterismo gu´┐Żnoniano e mistero cristiano, Arkeios, 2001).
[2] Gu´┐Żnon ´┐Ż tuttavia attento a definire la necessit´┐Ż dell'exoterismo tradizionale (a questo tema ´┐Ż dedicato un capitolo di Initiation et r´┐Żalisation spirituelle, una raccolta postuma di articoli, tr. it. Iniziazione e realizzazione spirituale, ed. Studi Tradizionali, Torino 1967).
[3] ´┐Ż ancora tutto da compiere il fecondo lavoro di identificazione di tutti i prestiti e le eredit´┐Ż che, nell'opera matura di Gu´┐Żnon, riecheggiano la sua formazione occultistica.
[4] Si vedano, ad esempio, in proposito, le opinioni espresse nel primo capitolo degli Aper´┐Żus sur l'Initiation (trad. it. Considerazioni sulla via iniziatica, f.lli Melita, Milano 1987, pgg. 25-31). In relazione al rapporto tra iniziazione e cristianesimo, anzi, Gu´┐Żnon non manca di osservare che, se ´┐Ż vero che lo Spirito Santo interviene tanto nei rituali esoterici che in quelli exoterici, ´┐Ż anche vero che tale intervento ´┐Ż destinato a sortire effetti del tutto diversi, solo nel caso dei rituali propriamente iniziatici afferenti al dominio della vera realizzazione spirituale (cfr., ad es., quanto affermato nel secondo capitolo di Aper´┐Żus sur l'´┐Żsot´┐Żrisme chr´┐Żtien - trad. it. Considerazioni sull'esoterismo cristiano, ed. il Settimo Sigillo, 1987). Il contenuto originariamente esoterico delle rituarie cristiane ´┐Ż oggi, in sostanza, secondo il Gu´┐Żnon, esaurito, essendo sopravvissuto il solo aspetto exoterico. Gli stessi sacramenti non costituiscono che una esteriorizzazione exoterica di originari riti esoterici. Gu´┐Żnon non precisa per´┐Ż in cosa consista una tale esteriorizzazione, e con quali tappe il sacramento perde la presunta qualificazione esoterica. Assai problematico, in rapporto alla natura stessa dell'intervento dello Spirito Santo, cos´┐Ż come esso ´┐Ż trasmesso e presentato nella dottrina cristiana.
[5] Cfr. Iniziazione e realizzazione... cit., cap. 8. Realmente, risulta assai confuso ed impossibile da comprendere la collocazione che il Gu´┐Żnon attribuisce alla patristica, dal lato dottrinario. Come si qualificheranno gli scritti di S. Giovanni della Croce, o quelli di un Silesio o di un Gregorio di Nissa? Di contro rimane assai dubbio il valore reale che i sacramenti, dal punto di vista di Gu´┐Żnon, avrebbero dovuto avere nella loro purezza originaria in rapporto ad alcune sue teorie inerenti la differenza tra iniziazione virtuale ed iniziazione effettiva (cfr. il capitolo XXX delle Considerazioni... cit.).
[6] Tanto per la cronaca, sarebbe ora di ricordare che l'intero impianto dottrinario delle regole - come, in parte, quello organizzativo, per quanto ci ´┐Ż dato sapere - degli ordini cavallereschi, attinge a normalissime regole monastiche. Borella nota come sia curioso, del resto, che le prove - se tali possono definirsi le ardite ipotesi e deduzioni talvolta invocate - a favore di una regolare filiazione esoterica - in senso gu´┐Żnoniano - in seno al cristianesimo, non siano mai anteriori al XII secolo. Reyor considera interne alla filiazione cristiano-esoterica, anche il rosicrucianesimo, esperienza affatto moderna, sviluppatasi, peraltro, per larga parte della sua genesi e della sua produzione testuale, in ambito protestante e scismatico, in aperto ed aspro conflitto con i tradizionali rappresentanti dell'exoterismo cristiano (la chiesa romana). Il che, ci pare, mal collimi con l'idea della dialettica funzionale esoterismo-exoterismo, che si pu´┐Ż desumere dalle dottrine gu´┐Żnoniane. E, d'altro canto, ´┐Ż proprio in quell'epoca ed in quegli ambienti che esistono prove documentali della formazione di societ´┐Ż e confraternite esoteriche dai caratteri compatibili con quelli teorizzati da Gu´┐Żnon.
[7] In merito alla presunta segretezza, di cui sarebbe ammantata la scuola esoterica cristiana, ´┐Ż opportuno ricordare un passo evangelico che, riteniamo, non debba dar adito a dubbi di interpretazione: "...Non vi ´┐Ż nulla d nascosto che non debba essere rivelato, e di segreto che non si debba sapere. Quello che vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce del sole; e quello che vi ´┐Ż stato detto all'orecchio predicatelo sui tetti" (Matteo, X, 26-27, corrisponde a Luca XII. 3, ed a Luca VIII, 17). Una istruzione del Cristo, se possibile, ancor pi´┐Ż chiara ed universalistica di quel bevetene tutti, che rappresenta uno dei passi pi´┐Ż importanti del rituale eucaristico.
[8] "Avendo dunque, o fratelli, per mezzo del sangue di Ges´┐Ż Cristo, la sicurezza di entrare nel santuario per questa via nuova e vivente che egli ha aperto per noi attraverso il velo, cio´┐Ż attraverso la sua carne" (Ebrei, X, 19-21).
[9] Matteo, XXVII, 51, Marco XV, 38, Luca XIII, 45.
[10] Questa convinzione si fa abbastanza evidente quando, ad esempio, il Reyor, scavalcando ogni considerazione in merito alla lingua liturgica tradizionale, il latino, cerca le radici della lingua sacra del cristianesimo nell'ebraico.
[11] Borella (op. cit.) evidenzia a tal proposito il passo degli Atti (X, 44-46), che rompe la tradizione del "popolo eletto". Lo Spirito Santo che scende sui presenti alle parole di Pietro, infatti effonde la sua grazia anche sui gentili non circoncisi, ed allo stupore dei circoncisi Pietro risponde: "...possiamo forse negare la l'acqua del battesimo a coloro che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi?...". Poco oltre a Pietro viene rimproverato di frequentare case dei gentili.- Ancora una volta appare opportuno ribadire che, la rottura netta ed esplicita nei confronti della tradizione ebraica - e l'infrazione sistematica dei suoi dettami rituali da parte del Cristo - che sarebbe fin troppo facile rintracciare in vari passi scritturali, implica la necessit´┐Ż di una considerazione profonda degli aspetti peculiari e nuovi della rivelazione evangelica.
[12] Su questo cfr. Borella, Op. cit. pag. 111-112.
[13] Significativamente, come abbiamo detto, Reyor non affronta il problema della exoterizzazione del cristianesimo. Indubbiamente, l'autore ´┐Ż consapevole degli insormontabile problematicit´┐Ż di un simile assunto, che, con ogni evidenza, ignora le radici dottrinarie e teologiche dei sacramenti - e della grazia da essi conferita - cos´┐Ż come la tradizione cristiana li intende. Tuttavia, a questo proposito, anche negli studi di Reyor, notiamo una cosa che gi´┐Ż ci provoc´┐Ż stupore alla lettura dei passi Gu´┐Żnoniani dedicati al cristianesimo: la quasi totale assenza di riferimenti alla tradizione patristica, e l'abbondanza, invece, di riferimenti alla tradizione ebraica. Un curioso metodo ermeneutico che ottiene l'inedito risultato di considerare un cristianesimo avulso dalla sua stessa tradizione teologica e metafisica, ed accostato invece a tradizioni estranee, nel cui ambito si ricercano radici e corrispondenze sulla base di astrazioni ed accostamenti spesso problematici.