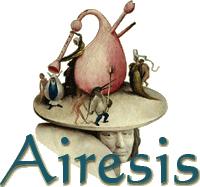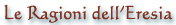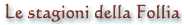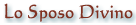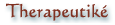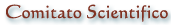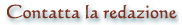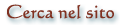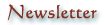I topoi letterari della morte nera
Il teatro della peste
Ida Li Vigni - Universit´┐Ż degli Studi di Genova; Liceo Artistico Statale Paul Klee, Genova
Morbo cronico, implacabilmente ricorrente tanto da condizionare i comportamenti sociali ed economici dell'Europa per almeno tre secoli, la peste - questo "grande personaggio della storia di ieri", come la definisce sinteticamente Bennassar[1] - ha provocato uno stato di ansia e di paura cos´┐Ż uniformemente radicato e diffuso da creare una sorta di rappresentazione mentale universale del flagello, uno stile unitario e ripetitivo che dalla Bibbia, da Tucidide e da Procopio di Cesarea si prolunga fino a Defoe, Manzoni e Camus.
Nasce cos´┐Ż una "letteratura della peste" sganciata dalla contingenza dell'esperienza individuale o storica e risolta in un nucleo ristretto di topoi rappresentativi destinati a ripresentarsi ogni volta che il cupo delirio del contagio rende incerti i rapporti umani e frantuma la scansione rassicurante dell'agire quotidiano.
La Scandalosa, bassorilievo in cera policroma, ignoto del XVII secolo. Napoli, Congrega di Santa Maria.
Si potrebbe supporre che, dinnanzi al disgregarsi della comunit´┐Ż e dell'individuo sotto i colpi del nemico invisibile che assedia dall'interno la citt´┐Ż o l'uomo, non vi sia altra soluzione che fissare in qualche modo le sequenze puntuali della lacerazione e della sofferenza. Come dichiara dolorosamente Rieux, il medico camusiano:
...c'era nella sciagura una parte d'astratto e d'irreale. Ma quando l'astratto comincia ad ucciderti, bisogna ben occuparsi dell'astratto...[2]
Cos´┐Ż, letterati e non letterati affrontano l'astratto armati solo della parola, di quel logos ordinatore a cui si chiede di dare un volto al nemico, di salvare gli ultimi frammenti di una esistenza offesa e negata. E se il popolo annota diaristicamente la propria miseria senza riscatto e lo sgomento che lo coglie nel ritrovarsi in una solitudine improvvisa[3], i letterati si sforzano di ricondurre il tragico corrompersi del tessuto urbano e umano all'interno di poche ma costanti proiezioni iconologiche il cui violento realismo morboso traduce in parola l'incubo fattosi realt´┐Ż, in un tentativo estremo di rimozione e neutralizzazione. Accanto ad una scrittura privata, diaristica, fatta di nomi, cifre ed improvvisi vuoti, coesiste dunque una scrittura dell'eccesso, frantumata in microstorie esemplari, in cadenze monologiche, in frenetici quadri dell'orrore. Una scrittura iperbolica, inequivocabilmente "barocca", il cui ricorso agli artifici della retorica non nasce dalla esigenza del "bello scrivere", ma dalla necessit´┐Ż di dar corpo e voce allo straniamento angoscioso che coglie l'uomo quando si trova a dover fronteggiare l'inatteso, l'indecifrabile. Ecco nascere allora la serie fissa delle metafore che indicano il funesto diffondersi del morbo e che parallelamente, quasi per un inconscio desiderio di rimozione e di fuga, servono a procrastinare il momento in cui il flagello deve necessariamente tradursi nella parola temuta: peste.
Una reticenza, un mascherare il nemico, che dai bollettini di Sanit´┐Ż e dai dispacci ufficiali si trasmette ai cronisti, agli storici, ai predicatori, ai medici e agli artisti stessi. Cos´┐Ż, i testi parlano di "piaghe", in dichiarata analogia con quelle bibliche che punirono l'Egitto ma con un malcelato richiamo ai corpi enfiati e piagati che ammorbano la citt´┐Ż appestata; di "nubi divoratrici" che, spostandosi da una contrada all'altra, seminano la morte al loro passaggio, emblematici messaggeri di quegli astri che, congiungendosi o opponendosi, provocano il sorgere del mortale contagio; di incendi, di "pioggia di frecce", quando ad accendere la scintilla della mortalit´┐Ż non ´┐Ż il lugubre cavaliere dell'Apocalisse, il "nemico formidabile"[4], la "fiera crudele":
...Stette questa fiera crudele serrata fuori della Citt´┐Ż per molti giorni, quasi legata et sequestrata, ma alla fine tamquam leo rugiens, qui circuit querens quem devoret, entr´┐Ż per permissione divina [...] et fece a guisa di rabioso e mordente cane [...] Cos´┐Ż a punto fece questo non cane ma arabiata tigre... (Giovan Pietro Trevi, Historia della Peste, et febbri pestilentiali..., Novara 1630).
Le metafore dell'incendio e della pioggia di frecce sono indubbiamente le pi´┐Ż diffuse e meriterebbero una trattazione a parte, non fosse altro che per la fortuna iconografica che hanno avuto e per l'attivazione di particolari riconoscimenti a santi o sante (come San Sebastiano e Santa Barbara) obliati o relegati in secondo piano dalla Chiesa. Basti qui annotare che laddove il fuoco si presta analogicamente a rappresentare la furia del pestifero contagio (come attesta, tra l'altro, lo slittamento semantico per il quale anche il morbo "s'appicca"[5] e "s'avventa"):
...E fu questa pestilentia di maggior forza perci´┐Ż che essa dagl'infermi di quella per lo comunicare insieme s'aventava a' sani, non altramenti che faccia il fuoco alle cose secche o unte quando molto gli sono avvicinate... (Giovanni Boccaccio, Decamerone, Introduzione).
...parea che Milano in poco tempo, essendo cos´┐Ż fieramente accesa, si avesse a consumare nell'incendio di essa... (San Carlo Borromeo, Memoriale ai Milanesi, Milano, 1565).
...La pestilenza ´┐Ż come un grande incendio [...] se s'appicca a una citt´┐Ż costruita con le abitazioni l'una vicina all'altra e si sviluppa, il suo furore cresce, infuria per tutta la zona, e distrugge tutto quello che pu´┐Ż raggiungere... (Daniel Defoe, La peste di Londra).
la pioggia di frecce convoglia tanto l'idea della punizione divina, cos´┐Ż cara ai predicatori, quanto quella della subitaneit´┐Ż subdola del morbo, a cui nessuno - giovane o vecchio, ricco o povero - pu´┐Ż sfuggire.
In questo caso il modello letterario ´┐Ż da ricercarsi nel noto passo del canto I dell'Iliade, mediato in chiave cristiana da un episodio della Legenda Aurea di Jacopo da Varagine in cui a San Domenico appare la visione di Cristo armato di tre lance in atto di colpire l'umanit´┐Ż colpevole. Ed ´┐Ż un tema, questo della punizione divina che cade dall'alto, che domina ossessivamente l'iconologia devozionale e che ci rimanda, sul piano meramente iconografico, a quei Trionfi della Morte (sempre pi´┐Ż diffusi proprio a partire dal 1348) in cui uno scheletro ghignante scocca i suoi strali mortali su uomini e donne di ogni et´┐Ż e di ogni condizione sociale.
Se si confronta, dunque, il ricco materiale iconografico con quello letterario ci si rende conto immediatamente che ci´┐Ż che maggiormente colpisce gli spettatori/attori della peste ´┐Ż la repentinit´┐Ż dell'attacco del morbo, il suo colpire, attaccarsi a tutti e a tutto, il suo distruggere in pochi istanti l'ordito rassicurante delle relazioni sociali. Se ´┐Ż vero che si ´┐Ż consci, gi´┐Ż a partire dal Boccaccio, della parziale selettivit´┐Ż del contagio, che colpisce e decima soprattutto i poveri (a cui era negata, peraltro, persino la pur economica "pillola dei tre avverbi": cito, longe, tarde), ´┐Ż altrettanto vero che, nell'infuriare del morbo, i quartieri si spopolano con la stessa velocit´┐Ż con cui si colmano le anonime fosse comuni.
Ci´┐Ż che traumatizza gli "osservatori" della peste non ´┐Ż tanto l'alta mortalit´┐Ż che la contraddistingue, bens´┐Ż l'irrompere sulla scena di una morte scandalosa ed oscena, di un'agonia che non conosce n´┐Ż il pudore della "buona morte'", n´┐Ż il conforto post mortem dei consueti rituali funebri. In una societ´┐Ż in cui la speranza di vita e bassa e che quindi convive con l'idea di una morte che ´┐Ż presenza dolorosa ma in fondo domestica, la peste introduce la rivelazione di un morire "sporco", che deturpa il corpo e sconvolge le menti, di un nemico invisibile che coglie i popolani intenti alle loro faccende quotidiane:
´┐Ż
Il carro dei monatti di fronte al Lazzaretto (1630).
...Cose terribili accadevano in questi mercati. C'era gente che aveva la peste addosso e non lo sapeva, cos´┐Ż usciva per fare la spesa e moriva in mezzo a tutti. D'un tratto un uomo o una donna piombava a terra cadavere, mentre era l´┐Ż con la mano tesa per pagare... (Daniel Defoe, La peste di Londra).
E che non rispetta neppure i dottori intenti ad incidere un bubbone, i monatti che trasportano i cadaveri[6], i fedeli che seguono le reliquie del santo patrono portate in processione per le vie della citt´┐Ż[7].
La peste, dunque, nell'immaginario collettivo, ´┐Ż soprattutto questo: una presenza misteriosa e sfuggente che si annida nelle coperte, negli abiti o persino in un fiore[8], nei semplici oggetti di una quotidianit´┐Ż che si palesa all'improvviso, senza ragione alcuna, insidioso strumento di desolazione e di morte. Si muore per una camicia rubata, per un bucato della vicina sottratto agli avidi commissari di Sanit´┐Ż, per aver nascosto la balla di seta indispensabile a garantire la sopravvivenza o per aver curato in casa il parente o l'amico che non si vuole abbandonare all'inferno senza speranza del lazzaretto. Si muore per quelli che sono i consueti gesti che scandiscono i rapporti sociali, di vicinato, ma si muore anche perch´┐Ż, folli di paura, ci si abbandona disperati alla frenetica bramosia di vivere:
...Si cercarono i profitti e le gioie veloci, poich´┐Ż sia la vita che le ricchezze erano egualmente effimere [...] Il piacere e tutti i mezzi per raggiulgerlo, ecco ci´┐Ż che era ritenuto bello e utile; nessuno veniva pi´┐Ż trattenuto n´┐Ż dalla paura degli d´┐Żi, n´┐Ż dalle leggi degli uomini... (Tucidide, La guerra del Peloponneso, l. II, cap. LII).
...Nel sacro giorno dell'Ascensione nel quartiere cittadino denominato Tosa alcuni scellerati si sfrenavano in giochi, dissolutezze e balli. Accadde che a sera furono trovati tutti contagiati dalla peste e tratti nel recinto del lazzaretto ove morirono, nessuno escluso... (Federico Borromeo, De pestilentia, Milano, 1630).
Vi ´┐Ż, nelle pagine degli storici della peste o dei letterati che in essa hanno individuato il nucleo esistenziale del male di vivere[9], ricorrente lo smarrimento di chi, dinnanzi allo "spettacolo orribile a vedere"[10] della citt´┐Ż vuota e silenziosa, scopre con orrore non soltanto l'emergere di irrefrenabili pulsioni[11], ma altres´┐Ż lo sfaldarsi del corpus sociale e dei legami affettivi sotto il peso di mostruosi sospetti e di incoercibili paure, come annota dolorosamente il Manzoni allorch´┐Ż fa proprie le angosce e gli interrogativi della fonte seicentesca da cui attinge:
...E mentre, dice il Ripamonti, i cadaveri sparsi, o i mucchi di cadaveri [...] facevano della citt´┐Ż tutta come un solo mortorio, c'era qualcosa di pi´┐Ż brutto, di pi´┐Ż funesto, in quell'accanimento vicendevole, in quella sfrenatezza e mostruosit´┐Ż di sospetti [...] Non del vicino soltanto si prendeva, dell'amico, dell'ospite; ma que' nomi, que' vincoli dell'umana carit´┐Ż, marito e moglie, padre e figlio, fratello e fratello, erano di terrore; e, cosa orribile e indegna a dirsi! la mensa domestica, il letto nuziale, si temevano, come agguati, come nascondigli di venefizio... (Alessandro Manzoni, I promessi sposi, cap. XXXII).
Il "venefizio": ecco l'ultimo topos che i testi ci trasmettono, ultima rappresentazione delirante di un viaggio senza ritorno nella indecifrabilit´┐Ż del Male, estremo tentativo di dare un volto al nemico comune. Assuefattisi allo spettacolo delle violenze, delle sofferenze, del patetico[12] e della decomposizione, registrata la vanit´┐Ż delle spiegazioni "naturali", esaurite le preghiere e le penitenze, agli uomini di cultura non resta altro che far proprio l'ultimo fantasma dell'inconscio collettivo: l'untore, lo straniero venuto ad avvelenare la citt´┐Ż, la vita stessa.
Nessuna meraviglia, quindi, se uomini per certi versi illuminati o comunque profondi conoscitori della natura umana come Federico Borromeo o fra Benedetto Cinquanta (autore di una straordinaria "rappresentazione sacra" post pestem)[13] finiscano con l'abbracciare, sia pur con caute riserve, l'idea del complotto venefico e satanico. Quando cadono le ultime barriere della ragione e la diffidenza verso l'altro da s´┐Ż assume forme patologiche, ´┐Ż normale convogliare le accuse ed i sospetti su quanti vivono ai margini della societ´┐Ż, sui "diversi" e i "malati", ovvero su coloro che minacciano con i loro comportamenti asociali l'integrit´┐Ż della comunit´┐Ż stessa.
Mal tollerati in tempi di normalit´┐Ż, i devianti diventano nell'in´┐Żfuriare del contagio i capri espiatori di un malessere che non ha pi´┐Ż nulla di contingente ma che presenta tutti i tratti della negativit´┐Ż metafisica, tanto pi´┐Ż che spesso in questi "seminatori di pe´┐Żste" non ´┐Ż difficile scoprire, come ben aveva compreso Lutero, il desiderio di colpire gli altri, i "sani":
...Ma vi sono criminali ancora pi´┐Ż grandi: molti, sentendo in essi il germe della malattia, si mescolano senza nulla dire ai loro fratelli, come se sperassero di scaricare su di loro il veleno che li consuma. Presi da quest'idea, costoro vanno per le strade, entrano nelle case, arrivano al punto d'abbracciare i loro figli o i loro domestici, nella speranza di salvare se stessi. Io voglio credere che sia il diavolo ad ispirare tali gesti e che si debba accusare lui solo; ma mi hanno detto anche che una sorta di disperazione invidiosa spinge qualche volta tali disgraziati a spargere cos´┐Ż la peste, poich´┐Ż non vogliono essere i soli ad esserne colpiti... (Martin Lutero, Sammtliche Werke, XXII).
´┐Ż la scoperta, questa s´┐Ż scandalosa ed intollerabile, della pre´┐Żsenza "naturale" del Male nell'uomo; la rivelazione di quella oscura malattia dell'essere, sfuggita parzialmente al Manzoni cui repugnava accettare tale conclusione, che pu´┐Ż spingere l'uomo alla distruzione ma che, come ben compresero a secoli di distanza tra di loro Sofocle e Camus, riesce anche a far riemergere in una comunit´┐Ż assopita nel rassicurante torpore della quotidianit´┐Ż e della normalit´┐Ż il germe sacro del rimosso, dell'irrazionale[14].
Ecco allora che i giorni della peste ci si presentano come una sorta di teatro vivente dove si consuma il dramma della solitudine esistenziale dell'uomo. Ne ´┐Ż palcoscenico la citt´┐Ż o il lazzaretto, quel microcosmo infernale in cui si istituzionalizza la desocializzazione dell'individuo[15]; ne sono attori ed autori ad un tempo i cittadini abbandonati a se stessi in un universo irriconoscibile ove i consueti rapporti umani risultano rovesciati o annullati.
Qui, in ogni strada, casa o ricovero del lazzaretto, in una devastata geografia urbana ed umana, il tempo si raggruma e tende ad assolutizzarsi. Qui, il disordine sociale e morale rispecchia i frantumi di un'identit´┐Ż impaurita che non tollera lo scandalo della "cattiva morte", mentre gli eventi, le minime storie individuali, diventano gli atti tragici del dramma collettivo della umanit´┐Ż. Sotto i colpi ciechi del contagio, Eros e Thanatos irrompono sulla scena ed affidano al linguaggio del corpo e dei sensi (non pi´┐Ż alla parola, ch´┐Ż ormai ha esaurito nell'orrore la sua capacit´┐Ż di dare corpo al nemico, di conferire senso alla sofferenza) il difficile compito di esprimere i sussulti angosciosi della coscienza, il silenzio lancinante della vita.
Teatro dell'eccesso e dunque spazio sacro ed aleatorio in cui si incontra l'altro da s´┐Ż, la peste impone l'esperienza indecente della passiva contemplazione della morte altrui.
Inerme, l'uomo si trova a vivere l'anonima sofferenza dell' altro da s´┐Ż, si riconosce in colui che in silenzio abbandona la vita, muore con l'altro per morire a se stesso e diventare, come riconoscono i protagonisti de La peste di Camus[16], "colui che resta", colui che accetta di testimoniare fino in fondo, rinunciando alle facili consolazioni della fede e della scienza, l'assurdit´┐Ż del vivere nella speranza di sottrarre l'uomo al nihil che lo circonda.
´┐Ż
NOTE
[1] Cfr. B. Bennassar, Recherches sur le grandese ´┐Żpid´┐Żmies dans le nor de l'Espagne ´┐Ż la fin du XVI si´┐Żcle, Parigi 1969.
[2] Cfr. A. Camus, La peste, Milano, Bompiani, 1964.
[3] Cfr. Giovan Ambrogio de Chozo, Memoria de la pesta de Ian 1576 in Milano, in F.M. Ferro, La peste nella cultura lombarda, Milano, Electa, 1981. Significativo ´┐Ż anche quanto dichiara il sellaio protagonista de La peste di Londra di Daniel Defoe: "...Dedicavo il mio tempo libero a leggere libri e a scrivere il diario di quanto mi succedeva ogni giorno ...". Si scrive per non perdere i contatti con la realt´┐Ż quotidiana, per colmare i vuoti che il contagio provoca attorno a s´┐Ż, per sfuggire all'insicurezza generata dallo sconvolgimento dei principi sociali della convivenza.
[4] Cfr. D. Defoe, La peste di Londra, Milano, Bompiani, 1979.
[5] Cfr. M. Villani, Cronica, Torino, Einaudi, 1979.
[6] A tale proposito, e a titolo di semplici esempi, si veda una tela di N. Mignard, La peste d'Epire, conservata presso l'Istituto Pasteur di Parigi, ed un'incisione di W. de Haen al Museo Van Stolk di Retterdam.
[7] Cfr. A. Manzoni, I promessi sposi, Milano, Il Principato, 1988, dove la rievocazione della processione dietro le reliquie di San Carlo Borromeo s'accompagna alla constatazione, tratta direttamente dalle fonti seicentesche (Tadino e Ripamonti), della improvvisa impennata della mortalit´┐Ż.
[8] Cfr. A. Manzoni, Storia della colonna infame, Palermo, Sellerio, 1981 e gli Atti del processo agli untori (in G. Farinelli, E. Paccagnini, Processo agli untori, Milano, Garzanti, 1988). ´┐Ż il caso di Giovanni Battista Farletta, riconosciuto colpevole e condannato a morte per aver "appestato" il senatore Caccia con un fiore avvelenato.
[9] Cfr. A. Camus, La peste, ed. cit., il cui assunto ´┐Ż appunto la denuncia del male esistenziale di cui la peste ´┐Ż metafora metafisica.
[10] Cfr. D. Pio della Croce, Memoria delle cose notabili successe in Milano intorno al mal contaggioso l'anno 1609..., Milano, 1730, in F.M. Ferro, La peste nella cultura lombarda, ed. cit.
[11] L'episodio pi´┐Ż celebre lo offre ancora una volta Daniel Defoe quando ricorda il caso della gentildonna londinese assassinata da un appestato che, dopo averla inseguita e baciata, cos´┐Ż la apostrofa cinicamente: "...Ho la peste, bellezza. Perch´┐Ż non avresti dovuto averla anche tu?...". Ma non mancano, soprattutto nei cronisti, nei predicatori e nei fascicoli processuali, episodi ben pi´┐Ż macabri e rivoltanti che hanno per protagonisti monatti e infermieri del lazzaretto.
[12] Un esempio di patetico, presente sia nei testi letterari sia nei materiali iconografici, ´┐Ż offerto dal tema del neonato attaccato al seno della madre ormai cadavere. Su questa linea si pone l'episodio manzoniano della madre di Cecilia o quello della capra che allatta nel Lazzaretto un infante ricordato da Federico Borromeo nel De pestilentia.
[13] Cfr. B. Cinquanta, La peste di Milano del 1630, Milano, 1632, in Teatro tragico italiano, a cura di F. Doglio, Bologna 1960.
[14] Cos´┐Ż, nell'Edipo re di Sofocle, ´┐Ż proprio Edipo, lo straniero dai capelli rossi e dalla ben riconoscibile deformazione, a risvegliare nella comunit´┐Ż la coscienza del "male di vivere", assumendo su di s´┐Ż le colpe collettive e diventandone, ad un tempo, il contaminatore e il guaritore sacro.
[15] Il tema del lazzaretto come "inferno nell'inferno" emerge costantemente, quasi fosse un'ossessione dell'immaginario collettivo, dai testi. Questa struttura sanitaria, che sul piano pratico rappresenta almeno il tentativo di intervenire razionalmente sul contagio, ´┐Ż vissuta dalla collettivit´┐Ż negativamente, come luogo di reclusione e di separazione in cui la speranza di vita si abbassa drammaticamente.
[16] Cfr. A. Camus, La peste, ed. cit. e, in particolare, l'episodio in cui il sacerdote Paneloux, il dottor Rieux e l'ateo Tarrou assistono impotenti alla terribile agonia di un bambino.
´┐Ż
Articolo riprodotto per gentile concessione dell'autrice, che ne detiene i diritti. Riproduzione vietata con qualsiasi mezzo.